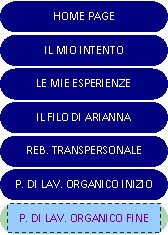|
RespirOrganico
|
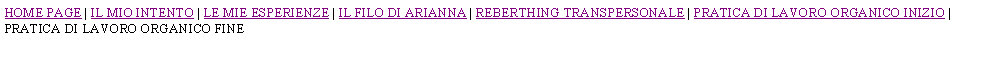
|
PRATICA DI LAVORO ORGANICO FINE |
|
Per ulteriori informazioni: |
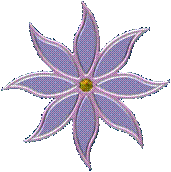

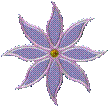
|
3.3 Un nome per il mio lavoro
Alla fine di quello stesso 1980, insieme ai due amici fraterni con cui condividevo l’avventura di curare il settore Animazione della rivista «Scena»(12), pubblicai un “Manifesto in morte dell’Animazione”. Dopo averne decretato la morte, con le tinte forti che il nostro linguaggio si portava ancora dietro dal ‘68, non potevo più dire di fare animazione teatrale e dovetti cercare un nome per il mio lavoro. L’antipatia per le definizioni e l’idea malsana che qualcosa di prezioso andasse protetto nascondendolo, me lo fecero chiamare, cripticamente, “Metodo di Lavoro Organico”: Metodo perché allora si parlava solo di metodi, in relazione alla ricerca, e io, non avendo ancora incontrato il pensiero delle pratiche di Carlo Sini - in cui la mia pratica avrebbe trovato un orizzonte teorico di inesauribile stimolo e il significato profondo del suo esercizio - non ero in grado di accorgermi che stavo frequentando più il territorio delle domande che quello delle risposte; Lavoro perché di lavoro su di sé si trattava, e Organico perché di organicità parlavano sia Grotowski che Victoria Santacruz(13) proprio nel significato che l’ascolto e l’attenzione alle costanti “precategoriali” di diverse tradizioni mi avevano indicato.
3.4 Il sapere organico
Sia nell’ipotesi di partenza del Teatro delle Sorgenti, che nelle parole di Victoria, riecheggia l’idea che all’organicità originaria corrisponda un sapere vitale e dinamico (che io chiamo appunto organico) progressivamente soffocato dalle costruzioni di un sapere appreso, statico e cristallizzato, votato al controllo. Anche Merleau-Ponty parla di “legami organici della percezione e della cosa percepita” in una pagina che descrive mirabilmente l’organicità di un processo soggetto all’ascolto:
Se quindi la riflessione non deve presumere di ciò che trova e condannarsi a mettere nelle cose ciò che poi fingerà di trovarvi, è necessario che essa non sospenda la fede nel mondo se non per vederlo e per leggere nel mondo il cammino che esso ha seguito divenendo mondo per noi, che cerchi nel mondo stesso il segreto del nostro legame percettivo con esso, che impieghi le parole per dire questo legame prelogico, e non conformemente al loro significato prestabilito, che si immerga nel mondo anziché dominarlo, che discenda verso di esso così come è anziché risalire verso una possibilità preliminare di pensarlo - la quale gli imporrebbe anticipatamente le condizioni del nostro controllo su di esso -, che lo interroghi, che entri nella selva dei riferimenti che la nostra interrogazione fa sorgere in esso, che gli faccia dire, infine, ciò che nel suo silenzio esso vuole dire…(14)
Organico, nella mia pratica, sta a indicare quel sapere che non sappiamo di sapere, che si manifesta nella continuamente rinnovata vitalità delle nostre risposte e nell’inspiegabile intelligenza con cui “qualcosa” in noi sa organizzarsi, per esempio, per farci passare dal sonno leggero (e non dal sonno profondo, come può fare la sveglia, con una botta allo stomaco) allo stato di veglia, quando ci siamo dati l’intenzione di svegliarci a una determinata ora. Organico è il sapere che sembra ritmare la vita secondo leggi inaccessibili a un pensiero razionale, ma evidenti, per esempio, nella maestria con cui i bambini si muovono nel territorio del sentire - «I bambini hanno il cuore puro. Per questo il Grande Spirito può mostrare loro cose che ai grandi sfuggono» dice Alce Nero e «I bambini vedono le montagne. Gli adulti non vedono più le montagne. Gli illuminati vedono le montagne» recita un detto Zen -.o nell’efficacia delle nostre intuizioni quando riusciamo a metterle in pratica invece che in dubbio, o nel procedere del pensiero magico(15) che, per similitudini e analogie, trova un ordine che si guarda bene dal distruggere perché dà senso e valore alla vita.
3.5 “Aprire l’ascolto... insegnare ad avvertire”
Come i bambini hanno fatto da guida a me e alle loro educatrici nei nidi, Nomad prima e Naka Chicala (leader spirituale dei Lakota di Cheyenne river) poi, mi hanno introdotta a rituali e insegnamenti degli Indiani d’America che rinnovano la sensazione di appartenere al “grande mondo degli esseri”, di essere “l’acqua della goccia”(16). Di quelle esperienze porto con me, oltre al calore di una relazione con il vivente, la chiave più semplice per un accesso privilegiato ai simboli che mi “rivelano il mondo”, come dice Sini riprendendo gli studi di Creuzer in un suo vertiginoso saggio sul simbolo e l’uomo:
Il discorso simbolico originario, dice Creuzer, aveva come oggetto la rivelazione […] il simbolo non è il segno convenzionale che rimanda a una verità condivisa [...] Il simbolo rivela il mondo all’uomo e lo colloca nel mondo [...] La natura parla all’uomo mediante segni. Non a tutti dapprima, ma solo a coloro che, per primi comprendono il suo linguaggio [...] E’ così che nascono i sacerdoti: coloro che intendono il linguaggio degli Dei(17) [...] L’ammaestramento originario non è un fornire nozioni chiare e distinte; è invece un aprire l’ascolto, un far luogo sollecitando l’attenzione, un insegnare ad «avvertire» [...] Dice bene Creuzer: qui siamo ben lontani dalla comprensibilità di una sapienza concettuale appresa,(18) ma siamo ben vicini all’esperienza di un corpo che si pone in ascolto se
Il luogo originario del simbolo è assai più da ravvisare in quel simbolo vivente che è il corpo in quanto capacità ostensiva, indicativa, espressiva. Solo l’uomo è capace di indicare, solo per lui ha senso il gesto che indica e rivela, orienta e manifesta; egli è questo corpo eminentemente simbolico che si intreccia con il mondo: luogo della somiglianza e del segno, luogo iconico per eccellenza in cui l’evento si rispecchia e si fa mondo(19).
3.6 Corpo in ascolto
Quando la domanda filosofica nasce da un corpo che si pone in ascolto perché ridiventa capace di sentirsi «risvolto della carne del mondo», direbbe Merleau-Ponty, «piega del foglio mondo», direbbe Sini, ridiventa capace di una relazione organica con il mondo come quella che sembrano segnalarci i bambini, le piante e gli animali, quando il corpo non si “sa” ancora o non si “sa” più, scisso dalla mente, si apre la possibilità di una pratica che potrebbe diventare esercizio consapevole di quel compito che Rilke, con la sensibilità profonda e l’altezza poetica di cui è capace, ci attribuisce :
Il nostro compito è quello di compenetrarci così profondamente, dolorosamente, appassionatamente con questa terra provvisoria e precaria, che la sua essenza rinasca invisibilmente in noi. Noi siamo le api dell’invisibile. Noi raccogliamo incessantemente il miele del visibile per accumularlo nel grande alveare d’oro dell’invisibile.
In questo tentativo di genealogia della Pratica di Lavoro Organico non posso dimenticare il contributo che, oltre ai bambini, mi hanno dato gli handicappati o diversamente abili (come finalmente si dice oggi), gli anziani, i malati terminali (pessima definizione, ma non ne “corrono” altre), tutta la schiera degli irriducibili che, con i loro spiazzamenti, hanno aperto nuovi orizzonti al mio errare, quell’errare a cui la “pratica filosofica” continua a dare senso e dignità. Senza tanti compagni di viaggio e tanti amici che, pur seguendo altre rotte, sono stati e sono fari per le nostre navigazioni solitarie, non avrei mai avuto il coraggio di mollare gli ormeggi e avventurarmi in mare aperto. Oggi posso anche tornare in porto, sentirmi a casa in compagnia di chi vive la filosofia, la poesia, la musica, la danza, il teatro, il clowning, la terapia e ogni altra attività umana come occasione per praticare l’arte di ascoltare. A loro dedico le indicazioni generali della P.L.O. che ho trovato nei boschi e in mare aperto, nei bambini piccoli e nelle guide di Grotowski, nelle persone che hanno sperimentato con me, nella filosofia antica e in quelle orientali e che continuo a trovare, sorprendendomi ogni volta che riesco a mettermi davvero in ascolto, nel nostro “sapere organico”.
|
|
Riferimenti bibliografici
ATTISANI, A., Un teatro apocrifo, Medusa, Milano 2006. ID., BIAGINI M., a cura di, Opere e Sentieri. Jerzy Grotowski testi 1968-1998, Bulzoni editore, Roma 2007.. BECK, C.J., Zen quotidiano, Ubaldini, Roma. CAMBRIA, F., Far danzare l’anatomia. Itinerari del corpo simbolico in Antonin Artaud, Edizioni ETS, Pisa 2007. CANDIANI C. L., Sogni del fiume, La biblioteca di Vivarium, Milano 2004. CHOGYAM TRUNGPA, Al di là del materialismo spirituale, Ubaldini, Roma. CIMATTI P., Conosci te stesso?, Mediterranee, Roma 1990. DEMETRIO D., Autoanalisi per non pazienti. Inquietudine e scrittura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003. GAMELLI I., Sensibili al corpo I gesti della formazione e della cura, Meltemi, Roma 2005. GARAUDY R., Danzare la vita, La Cittadella, Assisi 1973. GINGER S., La Gestalt, terapia del “con-tatto” emotivo, Mediterranee, Roma 1990. HADOT, P., Esercizi spirituali e Filosofia antica, Einaudi, Torino 1988. HEIDEGGER M., Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1997. HILLESUM E., Diario 1941-1943, Adelphi, Milano 1996. JUNG C.G., Ricordi, sogni, riflessioni, Il Saggiatore, Milano 1965. KRISHNAMURTI J., La sola rivoluzione, Astrolabio, Roma. LEONI F., Senso e crisi. del corpo, del mondo, del ritmo, ETS, Pisa 2005. MADERA R., Il nudo piacere di vivere, Mondadori, Milano 2006. ID., TARCA L.V., La Filosofia come stile di vita, B. Mondadori, Milano 2003. MATURANA, H., DAVILA, X., Emozioni e linguaggio in educazione e politica, Elèuthera, Milano 2006. MERLEAU-PONTY, M., Il visibile e l’invisibile, trad. it. di A. Bonomi, riveduta da M. Carbone, Bompiani, Milano 1993. MICHELSTAEDTER C., La persuasione e la rettorica, Adelphi, Milano 1992. NANCY J.L., All’Ascolto, Raffaello Cortina, Milano 2004. NIETZSCHE F.W., La Gaia Scienza, GTE Newton 1996. OSTASESKI F., Saper accompagnare, Mondadori, Milano 2007 PANIKKAR, R., La realtà cosmoteandrica, Jaka Book, Milano 2004. RILKE, R.M., Elegie duinesi, Einaudi, Torino 1978. RISSO, A., Pedagogia dell’attenzione (da una lettura di Simone Weil), Il Segnalibro, Torino 1994. SCLAVI, M., Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori, Milano 2003. SINI C., Il simbolo e l'uomo, Egea, Milano 1991. ID., Etica della scrittura, Il Saggiatore Mondadori, 1992. ID., Gli abiti, le pratiche, i saperi, Jaka Book, Milano 1996. ID., Figure dell’Enciclopedia filosofica, voll. I-VI, Jaka Book, Milano 2004-2005. ID., Il gioco del silenzio, Mondadori, Milano 2006. THICH NHAT HANH, La via della trasformazione, Mondadori, Milano 2004
Quest’articolo è pubblicato in Adultità, 27 aprile 2008, Guerini e Associati, Milano 2008
|
|
(1)Spesso ho la sensazione di lavorare sulla “scoperta dell’acqua calda”.
(2)Grotowski citava il passo di un testo antico che parla dell’uomo intero come di due uccelli: quello che becca il mangime a terra e quello, sul ramo dell’albero, che lo osserva. La stessa citazione l’ho trovata nel libro di S.Ginger (La Gestalt, terapia del “con-tatto” emotivo, Mediterranee, Roma 1990) ed è l’immagine più solidale, per me, con l’esperienza dell’osservatore, del testimone, della consapevolezza. Vedi, a proposito, il paragrafo L’Io-Io a pag 48 del libro di A. Attisani, Un teatro apocrifo, Medusa, Milano 2006.
(3)Parlo di bellezza come ne parlano gli Indiani d’America quando dicono che “Medicina è saper toccare la bellezza della vita” cioè la vita così come si dà a noi, prima di essere definita, “grigliata” e impacchettata in concetti dai dualismi del pensiero occidentale.
(4)C. Sini, L’origine del significato. Filosofia ed Etologia, Jaka Book, Milano 2004, p. 188. E ancora «1. c’è un conoscere per fare, un conoscere produttore di ”oggettività”, di “cose” e di “criteri” d’azione all’interno del peculiare triangolo semiotico della pratica agita. 2. C’è un conoscere per comprendere, un conoscere produttore di “soggettività”, sebbene questo sia un dire imperfetto; diciamo piuttosto: produttore di uno sguardo riflesso sugli abiti interni alle pratiche che in ogni istante frequentiamo.» pp. 188-189.
(5)direbbe ancora Sini.
(6)R. M. Rilke, Elegie duinesi, Einaudi, Torino 1978, p. 5.
(7)Gruppo formato allora da cinque guide del Teatro delle Sorgenti: Pierre Guicheney, Francois Liège, Marek Musial, Fausto Pluchinotta e Stefano Vercelli. Nel 1976 Grotowski aveva formulato l’ipotesi che all’origine del Teatro non ci fossero delle tecniche teatrali, ma “personali” o di lavoro “con se stessi” e che le sorgenti, di queste tecniche delle origini, fossero estremamente semplici, precedenti le differenziazioni delle varie tradizioni e culture, qualcosa di “dato” all’essere umano. Dopo quattro anni di esplorazioni in diversi luoghi del mondo, con un gruppo internazionale e interculturale, nel 1980 apriva la sua ricerca a persone esterne, interessate a entrare nella pratica come testors, per verificarne la validità.
(8)Jerzy Grotowski, Ipotesi di lavoro, in «Sipario», 1980, 404, p. 48.
(9)Non ho mai voluto e quindi non sono mai riuscita a comprendere come si possa separare la ricerca dalla vita e ricordo che proprio a tre delle guide dell’Avventura chiesi che relazione ci fosse per loro tra la ricerca e la vita, ricevendo queste risposte: “Devono essere completamente separate tra loro, una non deve interferire con l’altra”; “Sarebbe bello, ma è difficile metterle insieme”; “La vie séparée de la recherche c’est la merde!” a testimoniare che la maniera di riscoprire l’insegnamento di Grotowski, che si viveva come un esponente della trasmissione artigianale, poteva essere, per gli apprendisti, solo personale.
(10)Nel suo testo Il Performer Grotowski afferma: «Io sono un teacher of Performer (al singolare: of Performer). Teacher – come nei mestieri – è qualcuno attraverso il quale passa l’insegnamento; l’insegnamento deve essere ricevuto, ma la maniera per l’apprendista di riscoprirlo, può solo essere personale. Il teacher, come ha conosciuto l’insegnamento? Con l’iniziazione, o con il furto» in Antonio Attisani, Un teatro apocrifo, Medusa, Milano 2006, pp. 45-46.
(11)«Lo sfondo specifico per il Teatro delle Fonti è il fatto che la civiltà, che stiamo costruendo da numerose generazioni, ci ha privato della prima casa natia, della sensazione della “presenza dell’uomo nel grande mondo degli esseri”» Jerzy Grotowski, Ipotesi di lavoro, in «Sipario» 1980, 404, p. 46.
(12)Remo Rostagno, Maia Cornacchia, Marco Baliani, In morte dell’Animazione, in «Scena», 1980, 11/12, p. 61.
(13)Allevata in un ambiente culturale europeo, Victoria direttrice della compagnia peruviana Teatro y danzas negros, aveva ereditato una cultura africana, una cultura organica, come afferma nell’intervista Incontro con una donna straordinaria, a cura di Maia Cornacchia, in «Scena», 1981, 2, pp. 37-38 : «[in una cultura organica] il fine è sempre l’essere umano. Quando una cultura diventa intellettuale il mezzo diventa fine e l’uomo cade in trappola. [...] Ti faccio un esempio: la danza e la musica sono importantissime nella cultura organica perché il loro fine è di integrare sentimento e pensiero; ogni passo e ogni linea coreografica sono destinati alla comprensione dell’essere umano. Quando si perde questo, si danza ma non si sa che cosa sta succedendo. Il ritmo, che è così importante, ha perso la ragione di essere nella cultura intellettuale perché l’intelletto divide, divide e alla fine si perde nella divisione».
(14)Maurice Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 1993, p. 63.
(15)Mi riferisco a un pensiero magico che si mantiene ancorato alla “volontà di vita” e non si assoggetta alla “volontà di potenza” come spesso accade invece quando viene trapiantato in occidente da mode Sciamaniche e New age .
(16)Penso all’antica domanda “Sono la goccia d’acqua o l’acqua della goccia?” che R. Pannikar ripropone nel video di Werner Weick e Andrea Andriotto, Raimon Panikkar, 1. L’arte di vivere 2. Il sorriso del saggio, 3. La nuova innocenza, produzione TSI - Televisione svizzera 2000.
(17)C. Sini, Il simbolo e l’uomo, Milano, Egea, 1991, pp. 100-102
(18)Ivi, p.106
(19)Ivi, p.147
(20)A proposito della frequente solidarietà del loro dire, sia Grotowski che Sini, in contesti diversi, hanno ricordato che i cinesi non hanno una parola per dire “mente”, che se un cinese scrive “mente” scrive anche “cuore”.
(21)Rainer Maria Rilke, Lettere da Muzot, in R. M. Rilke, Poesie e Prose, tr.it. Le Lettere, Firenze 1992
(22)Ho scoperto, quest’estate, il bel libro di Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori, Milano 2003, che insegna a mantenere l’ascolto anche nelle difficoltà e nei conflitti: “Basta non prendersi troppo sul serio” direbbero gli Indiani d’America. |
|
Tel.: 347-5357638 E-mail: viviana@respirorganico.it |